Sandro Scandolara
Nostro cine quotidiano
Le Gorizie al cinema
Secondo tempo
Roberta Turrin Scandolara
“Erano i giorni migliori,
erano i giorni peggiori”
C. Dickens, Le due città
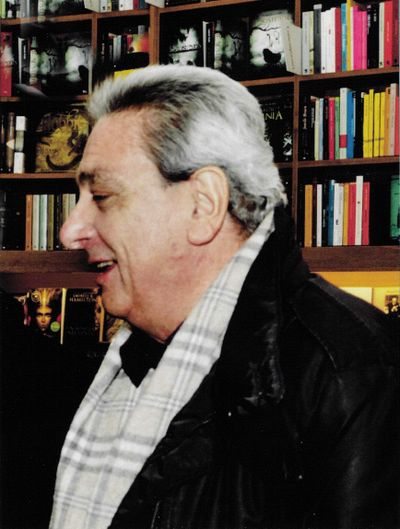
Erano gli anni settanta.
Al di là del carico di dubbi e di dolore di cui erano presaghi, il senso della possibilità sembrava prevalere sulla logica della rassegnazione. Lo stesso concetto di «arte» non si era ancora logorato del tutto, contaminandosi con quello di mercificazione, e rimandava a un’idea di radicale trasformazione della società e degli individui.
Erano gli anni settanta. E Gorizia manteneva la sua fama di città contesa e di città divisa. Un «muro» di filo spinato, fingendo di proteggerla, la intrappolava. Ma nonostante due guerre e una ancora in corso, sul terreno non erano rimaste solo le cicatrici.
Il caffè
«E adesso?! O vado a lavorare in banca o vado a vendere caffè!» Questa la scelta che Sandro in quegli anni, dopo un lungo vagabondare, pensava di avere davanti. Per lui, restìo a ogni forma di efficienza, pensatore esclusivamente per diletto, bastian contrario per inclinazione e formidabile irregolare, era la perfetta metafora di una vocazione e di un destino.
Tutti conosciamo la valenza simbolica che il pacchetto di caffè aveva allora nella zona del confine orientale. Insieme ai jeans costituiva il bene introvabile più ambito oltre la cortina di ferro. E se questi ultimi rappresentavano l’emblema della deviazione consumistica dell’occidente, il primo possedeva quel tocco in più di esotico che ne aumentava il fascino del proibito.
Lo si vendeva in ogni dove ed era soprattutto il Mattioni blu, che fungeva anche da vera e propria moneta di scambio. Nelle difficili transazioni ai valichi di confine per esempio, quando si cercava di far passare più merce del dovuto.
«Vendere caffè» appunto.
Come a dire il lasciapassare del sogno, la sospensione dell’incredulità. Nel caso di Sandro, come a dire Cinema.
Il cinema
Ecco il testo senza il "a capo":
Come attesta questo «volumetto», a Gorizia esisteva una lunga tradizione cinematografica. In particolare le sale di visione erano in gran quantità fin dagli anni cinquanta, rispetto alle potenzialità anagrafiche della città. Questo portava a «una politica gestionale di teniture brevissime, per cui ogni giorno si cambiava film e quindi si vedeva tutto. L’ottanta per cento di quanto edito sul mercato nazionale qui trovava uscita». Ma per Sandro Scandolara più che nelle sale cinematografiche la scoperta del Cinema avviene nella biblioteca della Stella Matutina, il centro culturale dei Gesuiti di Gorizia, dove padre Cattunarich raccoglieva tutte le più importanti riviste del settore. Ed è testimoniata da un giornalino al ciclostile in tre colori che commentava le proiezioni cittadine, confrontandosi con il parere dei più importanti critici nazionali di allora.
«Robert J. Flaherty più grande di Omero». Sandro, che era un grande affabulatore, oltre che un provocatore impenitente, raccontava di un suo tema scolastico in cui osava questa comparazione di fronte ad una insegnante allibita e priva degli strumenti culturali necessari per contestarla.
Tra le prime matricole alla facoltà di Sociologia di Trento, negli anni sessanta, è la scoperta della montagna e della sua marginalità culturale a interessarlo. Sull’onda di don Milani, nei due anni trascorsi a Cogolo in Val di Sole come insegnante di una scuola media, allora più fuori dal mondo di quella di Barbiana, organizza delle «trasferte culturali» mitiche. Come quella del teologo José Maria Gonzales Ruiz che andò lui stesso a prelevare in una stazioncina della bergamasca (chissà come c’era arrivato lì!?) e portò su in valle con una cinquecento scassatissima.
Ed è nel giro della controcultura e delle piccole case editrici che in quegli anni conosce il giornalista Sandro Zambetti, che lo porta a Bergamo, dove ha appena dato vita a un giornale controfeltriano (Vittorio Feltri era allora la voce ufficiale della città) che si chiamava «Bergamo contro».
Quando Zambetti diventa presidente della Federazione Italiana dei Cineforum, Sandro affianca alla collaborazione alla rivista omonima la gestione della sede di Venezia. Suo Eden privato quello, dove era immerso 24 ore su 24 nelle riviste di cinema di tutto il mondo, cui non smetterà mai di abbonarsi.
Gorizia città bifronte
La Gorizia dove più tardi torna è una città bifronte, segnata dalle antiche divisioni su un passato che non passava (e non passa ancora) e dalle nuove aperture che la ratifica degli accordi italo-jugoslavi aveva favorito non solo sul piano economico. Non si trattò quindi di un normale incontro con il proprio passato, fu piuttosto l’esigenza di un confronto necessario con i coinquilini dello suo stesso spazio, con i protagonisti della sua stessa Storia. E fu la presa d’atto di una lacerazione, la presa d’atto che su questa lacerazione si erano costruite delle identità. A cominciare dalla sua.
Le guerre cancellano mondi. Qui due guerre una dopo l’altra hanno negato e rimosso le potenzialità economiche-politiche-culturali di ampie fette di popolazione: la componente slovena e prima ancora quella austriaca (la borghesia austriaca da cui proveniva Nora Gregor), consegnando la città per decenni ai ceti medi improduttivi.
Inevitabili le conseguenze antropologiche oltre che culturali. Il senso di mancanza che ogni lacerazione produce. Quante le parole che non si usano più, i modi di dire dismessi. E il parlottìo plurilingue sempre più impercettibile! I libri, gli autori, i personaggi letterari, i protagonisti dei film, che sono stati relegati nei loro recinti di provenienza!
Su queste amputazioni allora era cresciuta un’intera generazione da entrambe le parti di un’unica città divisa. Una nuova generazione di giovani goriziani e novogoričani che avevano raggiunto l’età sufficientemente adulta per voler rileggere la Storia più recente al di là delle posizioni precostituite che avevano incancrenito il dibattito politico e la mentalità comune.
E poi c’era stato Basaglia! Un’esperienza la sua che, realizzatasi nell’indifferenza della città, se non addirittura nell’aperta ostilità delle forze politiche locali, aveva trasformato in realtà un’utopia. Un’esperienza che rappresentava un patrimonio da preservare, un modello di civiltà che si sarebbe potuto ripetere.
Non solo cicatrici, appunto.
Ricuciture
Riconoscere nei primi film sloveni della cinematografia jugoslava lo stesso skyline delle proprie passeggiate, veder prendere vita la silhouette di Nora Gregor catturata dalla pellicola di Jean Renoir, percepire l’ombra che si stacca da terra della «trapola de carta» degli intrepidi pionieri del volo fratelli Rusjan, ha significato allora per Sandro ricomporre una costellazione dai molteplici frammenti sparsi.
E furono nel tempo: la rilettura antologica con l’amico Darko Bratina del Cinema jugoslavo delle origini che divenne un programma in quattro puntate per la RAI nazionale nel 1983; la partecipazione a una serie di pubblicazioni del Kinoatelje sulla figura di Nora Gregor, l’attrice che qui aveva perso la sua patria d’origine senza più trovarne una nuova. Per continuare con le rubriche fisse sul Piccolo di Gorizia Nostro cine quotidiano: le Gorizie al cinema, che sviscerava il tema Cinema e Gorizia nel tempo e che fece da ossatura del libro omonimo qui ripubblicato. Piccola città era invece la rubrica che rileggeva, calendarizzandola, la storia di Gorizia desunta dai vari giornali portavoce.
Un lavoro di ricucitura di una realtà lacerata, incompleta, frammentaria, che contemporaneamente sul piano politico Darko Bratina Il cinema Gorizia città bifronte traduceva nel progetto di «Gorizia città ponte» e sul piano culturale Dario Stasi testava nelle pagine bilingue della sua rivista Isonzo Soča.
I giorni peggiori
Qui furono peggiori che altrove. Al confine orientale infatti, dove correva la prima linea di arresto dell’esercito nazionale prevista in caso di attacco da Est, il progetto eversivo della strategia della tensione ebbe una delle sue punte più alte con relativi depistaggi.
E mentre altrove in Italia i partiti tradizionalmente egemoni conoscevano nuove definizioni, predisponevano inedite alleanze nel tentativo di sopravvivere e di affrontare la violenza montante degli opposti estremismi; qui la maggioranza dei giovani che non si riconosceva in tali istanze trovò una piattaforma unificante nel partito di Marco Pannella, di cui in loco Renato Fiorelli era l’anima. Non solo per la rivendicazione dei diritti civili ma soprattutto per la denuncia di un sistema difensivo del tutto inadeguato e ormai astorico. Grande fu lo sconcerto politico che provocarono in città e in regione le marce antimilitariste condotte in tutto il territorio confinario delle caserme. Che videro la partecipazione di tanti giovani provenienti da tutta Italia, oltre a quella degli esponenti del Partito Radicale, di Dario Fo e Franca Rame, di Giovanna Marini e dei vari gruppi del Canzoniere italiano.
Quella che si formò allora fu una «comunità transfrontaliera».
Una comunità transfrontaliera
Era questa una comunità fortemente politicizzata, cosciente della propria identità storica, che non trovava spazio nei luoghi urbani deputati alle tradizionali forme di aggregazione. Per quanto riguardava il Cinema, il mercato era allora in piena ristrutturazione. Le sale cominciavano a risultare degradate e si ritrovarono inadeguate a rispondere alle potenzialità delle nuove tecnologie del tempo (sale a luci rosse, sale d’essai, le prime multisale). Scomparso l’estivo (anni cinquanta), scomparsi i cinema di paese (anni sessanta), le sale cittadine cominciavano la loro lenta agonia dopo la stagione dei Cineclub e del Cineforum della Stella Matutina. Da quella desertificazione sarebbero nati gli spazi nuovi del Kulturni dom e del Premio Amidei. Per allora si trovarono nuove stanze per il sogno che furono: prima una ex sala slovena per spettacoli in una corte di Corso Verdi, poi i locali di una ex fabbrica di sacchetti di carta in via Cadorna. Qui si proponevano, in spregio al mercato, prodotti alternativi che andavano dal Cinema delle lotte sociali a quello del Terzo mondo. La loro programmazione ordinaria era supportata dalla pubblicazione dei Quaderni di documentazione cinematografica e da quella del bollettino della Federazione Italiana dei Cineforum che veniva stampato nell’antica tipografia slovena.
Ogni appuntamento un’avventura. O perché la pellicola non arrivava in tempo e allora bisognava andare a recuperarla al deposito di Mestre. O perché il permesso di proiezione spesso mancava e allora si faceva ricorso all’intermediazione dell’avvocato Nereo Battello che aveva tutta l’autorità (e la voglia) di strigliare le forze dell’ordine per la loro intransigenza.
Comunque andassero le cose, mai sala cinematografica aveva raccolto un pubblico più trasversale, che andava dal vicequestore curioso, al cinefilo assetato di novità, all’ex partigiano mai interessatosi di Cinema, all’emarginato che cercava solo un po’ di caldo e naturalmente ai giovani delle due Gorizie che qui trovavano il continuum delle loro realtà separate.
All’inizio fu il frutto di un passaparola, poi una rete che i manifesti ad hoc di Franco Dugo e Luciano de Gironcoli contribuirono a tessere. Più tardi un foglio mensile che si chiamava Trenta sere cominciò a calendarizzare gli eventi. E furono il Piccolo Cineforum e la sua costola il Micron C.
Quando nel 1974 arrivò in città l’Italnoleggio (una società di stato che promuove il Cinema di qualità) a gestire il cinema Modernissimo, il nuovo pubblico, destinato a sostituire quello dei militari, tradizionali frequentatori della sala, era già seduto in prima fila.
Si susseguirono allora anteprime assolute, rassegne del Cinema cubano e del Cinema jugoslavo, personali su Vasilij Šukšin e Manoel de Oliveira. E siccome la nostra percezione nel mondo non è mai solo realistica ma si alimenta dell’apporto del sogno e del mito, ci furono anche i cicli sul rock, sulla fantascienza e sul divismo hollywoodiano.
La stella rossa di Natale
Nel frattempo, è la fine degli anni ottanta, il mondo sta cambiando in questa linea del fronte. Le avvisaglie di quanto stava accadendo si avvertivano tutte già nelle piccole cose. È il caso ad esempio delle ridicole mediazioni diplomatiche cui aveva portato un’iniziativa intrapresa in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano, per l’avvio di una serie di seminari estivi per studenti stranieri (soprattutto dell’Est Europa), da tenersi a Gradisca.
C’è stata una guerra, anzi più d’una e la stella rossa della stazione Transalpina di Nova Gorica è scomparsa nel buio di una notte, dopo che, nell’ultimo Natale della Jugoslavia, si era trasformata in una cometa con la coda luminosa. Lo stato di Tito è imploso e tra le altre cose con esso è imploso anche il progetto culturale-politico di un’unica cinematografia nazionale, che univa insieme le varie espressioni visive e linguistiche degli stati e delle etnie componenti la Federativa.
Il resto è storia di oggi. L’abbattimento del confine, l’allargamento dell’Unione Europea, la fusione delle due Gorizie nell’unica realtà della Capitale europea della cultura 2025. La costruzione di una vera e propria Cittadella del Cinema che, dal nucleo iniziale delle sale del Kinemax e dall’impegno di Aleš Doktorič nella direzione del Kinoatelje, si è allargata nel tempo fino ai nuovi progetti odierni. Dove i film si vedono ma anche si girano, dove il Cinema lo si legge e lo si studia.
Realtà e finzione
Quando uscì questo «volumetto» in occasione del millenario della città di Gorizia, le due città erano ancora percepite come «uno spazio franco alla periferia delle rispettive consapevolezze nazionali». Per dire quanta acqua sia passata sotto i ponti da allora e come queste pagine abbiano a loro modo tracciato il passo, c’è un’immagine del confine che può fungere da testimonianza del cortocircuito tra Realtà e Finzione / Storia e Cinema e del come la finzione sia sempre una sorta di verità.
Una fila di piccole persone, vecchie, acciaccate, mezzo addormentate, che a piedi passano il confine di Salcano la mattina presto di un 4 novembre degli anni settanta. Sono stanche perché hanno trascorso la notte in due corriere scalcagnate targate Potenza, parcheggiate in via Cadorna. Hanno affrontato un lungo viaggio sull’onda della memoria personale o familiare, per venire a visitare i sacrari della patria e magari per cercare un nome scritto sul marmo. Ma sembrano anche felici e si guardano attorno incredule per la fortuna di poter fare un’esperienza «proibita», che racconteranno per anni.
Si trattava di un film che quei poveri turisti della Storia si trovarono a recitare come comparse inconsapevoli. Un film di ispirazione antimilitarista per giunta, che il regista Giampaolo Bernagozzi girava in quei giorni a Gorizia sulla figura del reduce della prima guerra mondiale. Dopo una estenuante contrattazione con gli uffici preposti per ottenere il permesso di girare delle scene di qua e di là del confine, si trovò inaspettatamente a disposizione una marea di reduci veri per filmare una guerra finta.
Poi la sequenza fu giudicata troppo realistica per un contesto narrativo fortemente simbolico. Troppo patetica per un messaggio che giocava sui toni del grottesco. E così venne scartata in nome delle dure leggi della finzione.
Per quanto riguarda le dure leggi della realtà...: quanti pacchetti di Mattioni Blu sprecati quella notte!
(dal libro: Nostro cine quotidiano / Naš vsakdanji kino, Sandro Scandolara, ed. Kinoatelje, 2025)



